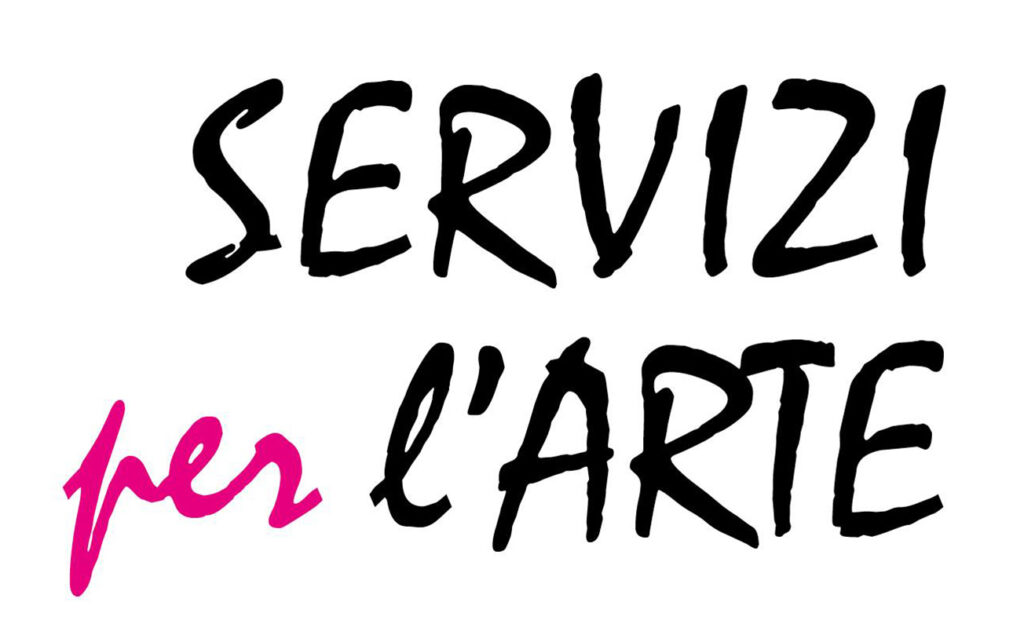dall’8 luglio al 22 settembre 2020
Gaggenau DesignElementi Hub, Milano
Cieli impossibili per avvicinarsi al mondo delle idee
testo critico e curatela di Sabino Maria Frassà
“Ho amato l’irraggiungibile in tutte le mie nostalgie” (Nazim Hikmet). Servono forse le parole di un poeta per spiegare a parole il lavoro di Davide Tranchina, l’enigmatico fotografo della distanza. Proprio la “distanza” – sempre incolmabile e irraggiungibile – è il concetto chiave per avvicinarsi a comprendere il mondo di questo artista; non la fotografia o la luce che sono “soltanto” gli strumenti attraverso i quali l’artista indaga, registra ed esprime la tensione all’infinito. Del resto i cieli di Davide Tranchina non esistono, sono “cieli impossibili” che allontanano il suo lavoro da altri noti fotografi, come Mike Olbinski, Michael Kenna e Chris McCaw, i quali hanno fatto invece del cielo l’oggetto principale della propria indagine.
Nelle sue opere Davide Tranchina dà forma alla proiezione ed espressione di un “io” collettivo archetipale: l’essere umano da sempre è spinto a guardare dalla terra il cielo e l’orizzonte. Da tale contemplazione nascono irrisolvibili dubbi ontologici che muovono l’uomo ad agire nel bene o nel male. Per Tranchina l’arte innesca tale movimento tanto nell’artista quanto nello spettatore “mosso” ad intraprendere un viaggio di consapevolezza e maturazione a partire dall’opera. Scriveva Rothko che “ci sono ancora così tante annotazioni che non riescono a spiegare i nostri dipinti. La loro spiegazione deve sorgere da una profonda esperienza tra immagine e osservatore. L’apprezzamento dell’arte è un vero matrimonio dei sensi”. Gli “interminati spazi e sovrumani silenzi” di Davide Tranchina raccontano un movimento immobile, uno spannung che non si risolve tanto forte è il senso di vertigine. E proprio il silenzio e la solitudine leopardiane sono due aspetti centrali e trasversali a tutta la ricerca dell’artista che completano la sua idea di “distanza”: le sue opere parlano di solitudine e di attese di un oltre non ben definito. Tante quindi le similitudini con i tagli di Lucio Fontana, con quel comune impeto ed invito allo sguardo dello spettatore ad andare oltre; non a caso i noti tagli di Fontana sono intitolati “Concetto spaziale. Attese” e raccontano dell’uomo di fronte all’enigma dell’infinito. Allo stesso modo Tranchina non ripropone immagini salvifiche, ma cosmogonie lontane che generano dubbi ed evidenziano i limiti stessi dell’essere umano così “solo sul cuor della terra trafitto da un raggio di sole”.
La distanza è la vera protagonista di “Cieli Impossibili” che sintetizza un pensiero formalizzato e formatosi in 13 anni di ricerca artistica: sempre implicita in tutti i lavori, la distanza diventa centro della ricerca e della rappresentazione di Tranchina per la prima volta nella serie “Quello che non c’è” del 2007¹. L’inconscio a volte è troppo precursore dei tempi e Tranchina non metabolizza per anni queste opere². Jung sosteneva però che “l’irrazionale non deve e non può essere estirpato. Gli dèi non possono e non devono morire. Guai agli uomini che vogliono disinfettare razionalmente il cielo”. Nel 2017 l’artista torna su questo ciclo di opere e sul tema dell’impossibilità di cogliere e raggiungere il cielo con un nuovo ciclo di opere che intitola Apparent Horizons. Dall’analisi di questi cicli di opere appare evidente un percorso dell’artista verso l’astrazione o meglio verso la sublimazione dell’immagine. Bisogna considerare che tale percorso è durato oltre un decennio durante il quale l’artista ha portato avanti altri lavori caratterizzati invece da una forte ricerca della figurazione, tra i quali Strada Stellare (2016) giunto dopo il successo di 40 notti a Montecristo (2012). Come ricorda lo stesso artista è questa figurazione, mai rinnegata, la molla per raccontare ed esplicitare meglio anche a livello visivo l'”irrazionale” junghiano, ovvero la distanza dal razionale. In Apparent Horizons si palesa completamente la transizione dalla stato “solido” della figurazione allo stato aeriforme ed etereo in cui prevale l’ambivalenza dell’apparenza: vengono meno la silhouette e l’immagine e la figura seppur presente è meno palese rispetto ai ” finti” cieli di Montecristo. Nei “cieli impossibili” di Davide Tranchina (Quello che non c’è 2007 e Apparent Horizons 2017-oggi) l’artista evoca una figurazione meno definita rispetto al passato: oggi le opere sono caratterizzate da linee e colori che portano lo spettatore a vedervi immagini di orizzonti, albe o tramonti. In realtà ciò che vede lo spettatore, come spesso nel lavoro di Tranchina, non esiste e non è mai esistito, sono cieli “volutamente” impossibili. L’artista innesca un cortocircuito sensoriale tra figurazione percepita e realtà registrata che provoca, in misura maggiore rispetto ai precedenti lavori più mimetici, una vertigine non solo per la distanza tra noi e il cielo, ma anche per l’ambiguità stessa dell’immagine: il “come se” spinge lo spettatore a domandarsi se ciò che vede sia realmente un orizzonte o meno. Per Tranchina l’arte e la fotografia non registrano ciò che l’essere umano riesce a percepire, quanto una realtà ontologica, ovvero l’arte fornisce gli elementi per vedere ciò che l’occhio umano – inteso come organo – da solo non riesce a cogliere. I cieli impossibili di Davide Tranchina, riduttivo e tecnicamente sbagliato definirli “scatti fotografici”, risultano così opere universali che colgono e danno forma all’inconscio archetipico dell’essere umano.
La pienezza di questo corpo di lavori è raggiunto anche attraverso un magistrale uso di tecniche offcamera, che permettono all’artista di realizzare senza mai rivolge il proprio sguardo, né tanto meno la fotocamera, al cielo. Anzi le opere sono create per lo più nello spazio chiuso dello studio, esponendo il materiale fotografico a luce naturale o artificiale. Senza mai diventare manierismo, ma con la volontà di dare forma non casuale e rigorosa alla propria ricerca, in questo ciclo di opere la tecnica fotografica diventa per la prima volta in Tranchina oggetto e non solo più strumento di indagine: le opere con passepartout nero segnalano l’utilizzo di luci proprie della camera oscura, mentre quelle con passepartout bianco le opere realizzate attraverso l’esposizione a luce naturale. Del resto se il lavoro di Tranchina risulta così immediato nella fruizione è proprio perché è in esso è sintetizzato il passato – tanto delle tecniche fotografiche quanto della storia dell’arte – in modo tale da generare qualcosa del tutto rivoluzionario: le opere si proiettano verso il futuro senza fratture con il passato. Il suo lavoro si presta perciò a molteplici e “concentriche” interpretazioni: dall’analisi filologica sulle luci in fotografia, al già citato Fontana, alla vicinanza con l’espressionismo astratto americano e in particolare con Rothko. Proprio con quest’ultimo l’artista condivide evidentemente l’intento di rappresentare atmosfere immateriali: se Rothko ha però concentrato la sua ricerca nella rappresentazione della sublimazione dell’esperienza terrena, Tranchina si è spinto oltre, travalicando la tridimensionalità terrena verso una sublimazione del “cielo”: le sue atmosfere diventano negli anni sempre più “marziane” grazie alla selezione di linee e forme impresse sulla carta fotografica sempre più nette che rimarcano il senso di distanza. Inoltre in Rothko non si ritrova alcun interesse nel rendere riconoscibile il soggetto rappresentato, mentre per Tranchina è invece fondamentale l’ambiguità nel fra credere allo spettatore di riconoscere delle forme nell’immagine rappresentata. Proprio per tale aspetto di Tranchina difficile la vicinanza a livello concettuale con il ciclo di opere Colours of Shadow di Sugimoto del 2012: non solo l’artista bolognese inizia prima la sua ricerca – nel 2007 – ma soprattutto egli considera la luce non quale soggetto da rappresentare, ma come mero strumento per indagare la tensione all’infinito³. L’aspetto utopico ed idealistico è in ultima istanza la vera “cifra” caratteristica che affascina l’artista e che completa l’onnipresente distanza; non la registrazione della forma della materia. In fondo tutti i “cieli impossibili” di Tranchina sono il racconto del viaggio dell’essere umano dalla terra al di là del cielo, al Mondo delle Idee: “L’utopia è come l’orizzonte: cammino due passi, e si allontana di due passi. Cammino dieci passi, e si allontana di dieci passi. L’orizzonte è irraggiungibile. E allora, a cosa serve l’utopia? A questo: serve per continuare a camminare” (EH Galeano).
¹Il titolo di queste opere deriva da un brano degli Afterhours “Quello che non c’è” del 2002 incentrato sul contrastare il crescente disincanto tipico dell’età adulta. Il testo riporta immagini di realtà che invece non esistono, tra cui l’alba, soggetto ripreso dalle opere di questo ciclo di Davide Tranchina.
²Alcune di queste opere sono state presentate al pubblico solo nel 2020 all’interno della mostra collettiva “Qui c’è un mondo fantastico”, Museo Nazionale della Montagna, curata da Veronica Lisino e da Giangavino Pazzola, 12 marzo – 8 novembre 2020.
³Sugimoto realizzò queste opere fotografando lo spettro di luce proiettato da un grande prisma, mentre Tranchina come visto utilizzò la luce come strumento per rappresentare l’infinito attraverso l’esposizione di carta fotografica alla luce.